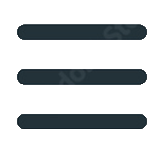|
VITA DI CONTRADA
testo ripreso da libro: "Siena, il Palio" di Giulio Pepi, edito dall'Azienda Autonoma del Turismo
Le Contrade, oggi, hanno dilatato attività e funzioni al vasto settore
del "tempo libero", senza tuttavia abbandonare nessuna autonoma
prerogativa territoriale, culturale, religiosa.
Sono "Enti giuridici territoriali", sulla cui determinazione (se
pubblici o privati) si è molto discusso, studiato e scritto fino a
raggiungere la conclusione, tratta da una recentissima istanza
autorevolmente accolta, secondo cui appare indubbia la "personalità
pubblica" in aggiunta e indipendentemente da quella "canonica" ad
alcune di esse già formalmente riconosciuta.
Si è fatto acutamente rilevare che la ruota della vita quotidiana di
ciascuna Contrada gira intorno a tre assi: la Chiesa, la Sede e la
Società, con l'aggiunta della stalla e di magazzini (come un tempo
avevano i "ridotti": ma questi servivano esclusivamente da depositi
militari).
La Sede è anche "museo" che raccoglie una documentazione di secoli.
Arredi sacri, lavori di oreficeria, costumi, documenti, pitture,
sculture lignee (alcune di famosi maestri), lapidi commemorative,
busti in bronzo, in marmo o ritratti di uomini che costituiscono anche
oggi mirabili esempi per le opere compiute fuori o dentro i confini
della Contrada, doni simbolici di affezione e memoria, Palii vinti,
gelosamente racchiusi e protetti da splendide teche. Lunghi anni in un
colpo d'occhio, passano attraverso i drappelloni (alcuni di pittori
famosi: da Guttuso a Maccari, da Purificato a Vespignani, Attardi, Dova,
Adami per breve citazione).
Sono immagini della vita che passa, degli ordinamenti che cambiano,
delle "epoche" e anche delle "mode" non sempre pacifiche e serene. In
alcuni troneggia lo stemma amico dei Lorena, in altri quello dirompente
di Napoleone, in quasi tutti (fino ad una certa epoca) gli stemmi
casalinghi dei "Deputati della Festa": un comitato di responsabili per
disciplinare lo svolgimento delle feste del Palio, di cangiante e
dilettevole storia. Compaiono i drappelloni giacobini (che cambiarono
gli stemmi con le iniziali del nome, in attesa della nuova araldica
imperiale), quelli risorgimentali con la croce di Savoia, con le
camicie rosse, per giungere alla comparsa dei fasci littori e al loro
declino.
Nella sede si tengono le assemblee a volte esuberanti della Deputazione,
del Seggio, del Consiglio generale anche oggi convocato - oltre che
con i mezzi resi accessibili dalle moderne tecniche delle comunicazioni
di massa attraverso l'affissione di manifesti negli appositi "albi",
murati sugli edifici di confine, e il suono della campana maggiore
della Chiesa.
Secondo lo Statuto che ogni Contrada si è data e al quale obbedisce,
nella Chiesa e nella Sede batte l'orologio della sua storia: dalle
nomine delle Commissioni fra cui, importantissima, quella elettorale,
che indica le votazioni generali per il rinnuovo del Seggio o del
Capitano, alle riunioni di lavoro serali, all'annuncio aperto
all'augurio delle nascite, alla partecipazione agli eventi che toccano
la comunità e ciascuno in quanto membro.
In Chiesa si celebrano i matrimoni, i riti in onore del Santo a cui è
dedicata, le manifestazioni di giubilo per la vittoria, le
commemorazioni dei defunti, le preghiere di invocazione o di
ringraziamento, la benedizione del cavallo e del fantino prima della
corsa. Una bandiera fermata da un nastro nero sulla porta, indica che
è anche "camera ardente", ultima sosta della salma di fronte all'altare
della speranza e al saluto degli amici.
In una visita a Siena, le Sedi e le Chiese delle Contrade, rappresentano
punti di riferimento che non possono sfuggire all'ospite attento: sia
per il loro contenuto demologico e culturale (il termine racchiude
anche gli esemplari storici e artistici di patrimonio universale), sia
per una approfondita presa di coscienza dell'originalità dello spirito
senese, sotto il profilo etnico, amministrativo, politico (nel senso
antico di cittadini di autonome "polis", che in una convergono).
È il percorso obbligatorio per coloro che davvero vogliono non
avventurarsi in banali o superficiali accostamenti, non formulare
affrettati e inconsapevoli giudizi (un altro è la visita - meglio
ancora la frequenza anche breve - della Società di Contrada) e
assistere poi al Palio con sufficiente e adeguata preparazione.
La Festa del Santo Patrono è una tappa di rilievo durante l'anno. Le
strade sono illuminate, le campane e la musica suonano, si ricevono in
forma solenne i rappresentanti delle Contrade "aggregate" le cui
bandiere sventolano lungo la via principale insieme a quelle della
celebrante. Il "Solenne Mattutino", recitato in questa occasione,
rappresenta l'osanna a Dio, nella concordia e nella fraternità, il
richiamo della Sua testimonianza, il momento di un rinnovato e antico
atto di fede, la richiesta della protezione al Santo, ma forse anche
l'umile, inconsapevole riconoscimento dell'armonia universale al di
sopra e al di fuori del finito.
L'avvenimento è predeterminato nel calendario annuale. Si svolge in
occasione della ricorrenza del Santo (o dei Santi o della Madonna nei
diversi titoli di culto) a cui è intitolata la Chiesa. Se l'anniversario
non cade di domenica, si va al sabato e alla domenica successiva (infra
ottava).
La sera del sabato, vigilia, è riservata alle manifestazioni che sopra
abbiamo brevemente descritto. La domenica, all'uscita dell'intera
"comparsa", diversa da quella del Palio, formata da sessanta o oltre
cento alfieri e tamburini. Per l'intera giornata, il numeroso gruppo
percorre le strade della città rendendo omaggio alla dimora dei propri
appartenenti (con la "sbandierata" di saluto), alle autorità, alle
Contrade amiche o "aggregate" (in termini antichi si chiama "effettuare
il giro").
Le "aggregazioni" risalgono molto indietro nel tempo. Negli ultimi
quaranta anni è stato stipulato solo un patto di questo genere. Mentre,
al contrario, molte alleanze sono state sciolte. Come la politica dei
grandi Stati, anche la politica delle Contrade è spesso fluttuante. Sono
costanti, di solito, solo nelle rivalità, quando addirittura non si
creano delle nuove.
Ma non è escluso che la "diplomazia" torni a ricucire vecchi strappi,
a colmare certe crepe, a smussare certe punte. Può darsi che il bisogno,
anche formale oltreché reale (il secondo "deve" sussistere), di sentirsi
amici dando e ricevendo, possa riemergere. Il futuro, al solito, è in
grembo di Giove.
Altre fasi significative dei festeggiamenti domenicali sono il
"battesimo" e il "rientro".
Il secondo è la rappresentazione dell'annuale rinnuovo di "appartenenza"
(riporta alla mente i medioevali cortei di "sudditanza") alla Contrada
di cui si fa parte. E'l'ultima fase del "giro", il ritorno (o "rientro")
in Contrada partendo spesso da Piazze ubicate agli antipodi della
città. Alla "comparsa", si unisce quasi sempre un corpo musicale e
sempre tutti i componenti il Consiglio, con il Priore e gli altri
maggiorenti in testa, gli uomini, le donne, i bambini (a volte
piccolissimi, ancora condotti sul carrozzino). È anche una dimostrazione
di prestigio e vigore di fronte agli altri, di gagliarda vitalità e
fierezza. Quando il corteo imbocca la strada principale della Contrada,
le campane suonano e la Chiesa accoglie tutti per il canto di finale
ringraziamento alla Vergine ("Maria mater gratiae").
Il "battesimo" è la consacrazione rituale di appartenenza alla
Contrada. Quasi tutte le Contrade hanno eretto fontanine in marmo,
in bronzo o in travertino, sempre con il simbolo in chiara evidenza
(fatta eccezione per alcune che preferiscono usare direttamente la
fontana del quartiere, a volte antichissima, dal cui nome spesso è
designata l'intera zona: Fontebranda, Pispini ecc.). Qui si ritrovano
tutti i bambini nati nell'intero arco dell'anno nel territorio della
Contrada, oppure i figli di contradaioli residenti al di fuori del
cerchio delle mura (confine giuridicamente invalicabile,
secondo il Bando di Violante) e, pertanto, in zona neutra, che seguono
non la regola dello "jus soli", ma quella dello "jus sanguinis".
Il Priore asperge sulla loro fronte l'acqua della fontana procedendo
al "battesimo" e dichiarandoli membri della Contrada fino alla
morte. Spesso si effettua un secondo rito riservato agli adulti. Sono
gli immigrati a Siena o i figli di immigrati, o semplicemente abitanti
di città o paesi vicini o lontani che hanno aderito alla Contrada,
hanno dimostrato con opere, entusiasmo, costanza, umiltà, di meritare
l'ammissione, e la ottengono (quasi sempre con anticipata approvazione
formale da parte del Consiglio o Assemblea Generale).
Il "battesimo" è una tradizione abbastanza recente: ebbe inizio nel
1949. Una dimostrazione come, nelle Contrade, nulla sia statico, nulla
possa invecchiare. Cadenti usanze, superate dai tempi o dalle esigenze,
si abbandonano e nascono nuove, in continuo evolversi.
Un grosso problema si affaccia in questi anni che attende una soluzione,,
ma che richiede, al contempo, profondo studio e altrettante
riflessioni. Pur constatando che mai le Contrade sono state così
impegnate e vitali, così esuberanti e realizzative, bisogna aggiungere che alcune sono cresciute
in proporzione diversa dalle altre, vanificando lo spirito stesso della
legge sui confini di Violante Beatrice di Baviera che voleva, per ogni
Contrada, un "egual numero di Abitatori".
Dentro le mura, ormai, abita un terzo della popolazione. Due terzi si
trovano nei nuovi quartieri residenziali che, in qualche caso, superano
l'area comunale. Le Contrade che hanno uno sbocco in contiguità con i
territori recentemente abitati, sono pertanto in vantaggio rispetto
alle altre, soffocate nel centro storico.
Infatti ufficiosamente (mai ufficialmente, salvo alcuni sporadici casi)
esse propendono ad ampliare in concreto la loro giurisdizione in zone
che, per ora, chiamano "di influenza". Questa tendenza è solo in minima
parte contrastata dalle famiglie che seguono rigidamente la regola
dello "jus sanguinis". Altre svariate circostanze complicano le cose
(ma non è questa la sede di trattazione), a tal punto, da costituire
motivi diretti a considerare possibile e non oltre procrastinabile un
nuovo provvedimento sui confini o, quanto meno, nuove regole
compensatrici.
Anche questo settore, in certo senso essenziale per il futuro, è in
movimento. Lo testimoniano congressi, dibattiti, assemblee, conferenze,
studi, progetti che fioriscono con periodicità sempre più intensa.
Ma è attraverso la Società, che la Contrada si ritrova quotidianamente,
che organizza le grandi iniziative, a volte allargandone la
partecipazione a tutte le rimanenti sedici e determinando avvenimenti
di rilievo non solo cittadino.
I gruppi sportivi, apparsi per la prima volta intorno agli anni venti,
sono particolarmente operosi nel calcio, ma anche nel basket, nelle
manifestazioni podistiche, nella palla a volo, perfino nello sci e nel
tiro al piattello o nelle gare di pesca.
Le "congreghe femminili" sono numerose e di grande efficacia, con
attività senza limitazioni né compartimenti.
Anche i bambini sono raccolti in gruppi, con responsabili addetti
(la figura moderna dei "maestri dei novizi"), per una educazione allo
spirito di Contrada, che significa prima ancora che alla propria "gens",
ai valori perenni di libertà, di amicizia e di altruismo, del vivere
insieme, della "senesità". Per loro, o direttamente con la loro
partecipazione, vengono concretate manifestazioni di ogni tipo
ricreativo e culturale, filodrammatico e rievocativo. E' antica e, come
vuole la tradizione, concepita, progettata ed eseguita dai ragazzi,
la "Festa dei Tabernacoli" l'8 settembre (giorno dedicato alla Natività
di Maria Vergine ). C'è anche un concorso sostenuto da enti culturali
e pubblici cittadini, per premi e attestati ai migliori addobbi che
ornano i "Tabernacoli" delle varie Contrade.
L'affinamento dei gusti, le dilatate e reali necessità, le aumentate
incombenze, hanno determinato continui lavori di restauro, ampliamento,
addirittura rinnuovi nel patrimonio immobiliare delle Contrade
(quartieri, Sedi, Chiese, Società).
Anche il settore assistenziale è vivissimo. Tutte le Contrade hanno
gruppi numerosi di donatori di sangue. Spesso si effettuano raccolte
per donare strumenti importanti nella terapia dei malati (rene
artificiale) o collette per rendere possibile il trasporto di alcuni
pazienti in cliniche modernamente attrezzate all'estero od offerte per
acquistare autoambulanze.
Non c'è segno di riposo o parentesi di ristagno. Certe Contrade hanno
utilizzato con arditi e geniali interventi le antiche cripte delle
proprie Chiese (alcune d'autore come quelle dell'Onda e della
Chiocciola), per ampliare i loro musei o le Società (Selva). Altre,
hanno ritrovato e messo in luce sale o stanze di antichissimi
castellari (Civetta) o ripristinato ambienti, da secoli interrati o
soffocati da materiale di riporto (Oca per la casa di Santa
Caterina). Lavori che arricchiscono notevolmente, anche sul piano
architettonico, oltreché storico e urbanistico, il patrimonio della
città.
La partecipazione al Palio, è una delle principali sollecitazioni della
Contrada ma, in tutto questo impegno, è presente - non confessata ma
sentita - la forza agonistica del vicendevole superamento che non si
compendia, dunque, nel Palio e per il Palio. Anche le rivalità
concorrono attivamente e costruttivamente. La spinta verso il meglio,
la prevalenza, l'orgoglioso prestigio. La stalla "più bella", la Sede
"più bella" , la Società "più bella". Si ritrova l'equivalente della
tendenza a un improbabile perfezionismo del carattere senese, che
spiega certe marcate originalità o periodi felici di produzione
culturale con grandi uomini che fecero "scuola", ma che possiede anche
risvolti di stizzosa polemica o di tenace insofferenza.
D'altra parte, poiché il Palio è l'esame di Siena attraverso le
Contrade (o viceversa), riflette, in qualche modo, la vita di un
anno o almeno, assolve alla pubblica presentazione dei diciassette
consuntivi due dei quali, con l'aiuto della sorte (necessaria come in
ogni atto umano), potranno elevarsi alla dignità di univoco simbolo
della autonomia vitale della città intera.
|
|
TUTTI I CAPITOLI DEL LIBRO
|
|