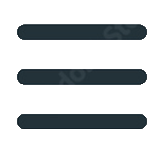|
PRELIMINARI AL PALIO
testo ripreso da libro: "Siena, il Palio" di Giulio Pepi, edito dall'Azienda Autonoma del Turismo
Cronologicamente, il Palio comincia con una prefazione (ma i fantini già
da qualche mese sono in allenamento nelle campagne più o meno vicine, i
cavalli "fanno il fiato" e i muscoli, i Capitani e i Tenenti di ciascuna
Contrada costruiscono con grande e ostinata pazienza la loro
strategia).
L'ultima domenica di maggio (o comunque non meno di venti giorni prima
del Palio), si procede alla estrazione delle tre Contrade che, come
abbiamo già visto, insieme alle sette che non hanno preso parte alla
corsa del 2 luglio precedente, disputeranno la giostra in onore di
Maria SS. di Provenzano. Le stesse regole, spostate nel tempo, valgono
per il Palio del 16 agosto: pertanto, non staremo a ripeterle.
È una cerimonia presieduta dal Sindaco, in una sala del Palazzo
Comunale, alla quale intervengono i Capitani delle diciassette
Contrade. Non scenderemo nei dettagli per brevità di narrazione. È bene
solo precisare che il Capitano (è colui che guida la Contrada nel
Palio (coadiuvato da due Tenenti o "fiduciari") e che ne detiene la
rappresentanza, riconosciuta di fronte alle autorità, sia in quei
giorni che per tutto quanto riguarda la celebrazione.
Avvenuto il sorteggio delle tre Contrade favorite dalla fortuna
(sorteggio che continua per le altre unicamente per determinare
l'ordine di sfilamento nel corteo), ne viene dato annuncio al pubblico,
che regolarmente si affolla in Piazza del Campo, con l'esposizione delle
bandiere precedute dagli squilli delle chiarine.
Le bandiere delle sette partecipanti di diritto sono esposte fin dal
mattino e, con le tre estratte, si completa il numero.
Le feste iniziano il 29 giugno (o il 13 agosto per il Palio
dell'Assunta). Nei giorni precedenti, Piazza del Campo ha cambiato
volto. Scrittori, giornalisti, cronisti si sono a lungo sbizzarriti,
con la fantasia, in centinaia di similitudini. La più giusta è forse
quella che la paragona a un "circo massimo": con la sola differenza
che la ribalta non è il centro, ma l'anello - ormai ricoperto di solida
cotenna di tufo - che lo circonda. Alcuni, in termini sportivi, lo
chiamano "pista". Intorno, lungo la base perimetrale dei palazzi, sono
state erette, senza soluzione di continuità, le tribune o, con termine
più spicciolo, i palchi. La gente può scegliere: o nelle poltroncine a
pagamento, o gratuitamente nella rossa conchiglia.
Primo atto, indispensabile e determinante (come ognuno può facilmente
comprendere), è la consegna dei cavalli alle Contrade. Si effettua per
sorteggio fra dieci, dopo la scelta fatta dai Capitani sui venti, trenta
soggetti presenti, che hanno dimostrato le proprie qualità, attraverso
corse in "batterie", ordinate e dirette dall'Amministrazione Comunale
e dai Deputati della Festa (tre persone nominate dal Comune, sentito
il Magistrato delle Contrade, che hanno compiti delicatissimi e
ragguardevoli da svolgere).
L'attaccamento al Palio, l'entusiasmo di partecipare in prima persona,
il prestigio morale che ne deriva, costituiscono la ragione principale
che spinge i proprietari a mettere a disposizione i loro cavalli.
Essi percepiscono un compenso modesto (sono però assicurati contro
incidenti che i "barberi" possono subire durante le corse). Ma la
preparazione di un cavallo per il Palio è lunga, laboriosa, non priva
di disagi e di impegni finanziari. La meraviglia di chi scopre questo
risvolto composto di sacrificio, è giustificata solo se non è rapportata
all'appagamento interiore del senese.
Il sorteggio, ovvero la "tratta", avviene nella tarda mattinata del 29
giugno (o 13 agosto). Subito dopo che hanno avuto luogo, ripetiamo, le
corse di prova di tutti i cavalli presenti, divisi in gruppi o
"batterie" di sette, sei, cinque.
E' una cerimonia pubblica. Nello spazio di fronte al Palazzo Civico è
stata in precedenza eretta un'impalcatura dove trova posto un lungo
tavolo, su cui vengono collocate due urne. Le urne contengono,
rispettivamente, dieci custodie in ognuna delle quali è racchiuso un
foglietto di pergamena contenente il numero che designa un cavallo (da
uno a dieci) e dieci custodie, nelle quali sono sigillati altrettanti
foglietti con i nomi delle Contrade partecipanti. A lato del palco, si
trovano dieci box entro i quali vengono condotti i cavalli prescelti.
All'annuncio fatto dalle chiarine, iniziano le operazioni, condotte dal
Sindaco, che ha precedentemente preso posto dietro al tavolo, con
l'assistenza dei dieci Capitani e dei Deputati della Festa. Dopo il
controllo, iniziano le estrazioni, materialmente compiute da due piccoli
paggi.
Prima un numero (corrispondente a un cavallo) e dopo il nome della
Contrada. L'abbinamento è fatto. Il "barberesco" in costume
rinascimentale (cioè l'uomo addetto al "barbero" e alla sua
manutenzione) preleva il cavallo e, fra l'esultanza dei propri
contradaioli o nel silenzio compunto (se le doti del corridore lasciano
poco margine alla speranza), lo conduce attraverso le vie della città,
verso la propria Contrada, nella stalla (più salotto che stalla).
Da questo momento la sorte sembra abbia già offerto certe indicazioni. Ma
è vero solo in parte. Perché il Palio può riservare le più abbaglianti
sorprese o le più cocenti delusioni.
Nel pomeriggio, al calare del sole, ha luogo la prima prova. È
importante, per entrare in possesso di elementi di giudizio più
precisi, soprattutto in merito ai cavalli che per la prima volta si
affacciano sulla pista del Campo. I tempi e le modalità della corsa
sono uguali a quelli del Palio, sia pure sotto il solo aspetto
tecnico.
Una volta sgombrato il percorso dal pubblico (i palchi e il centro
della Piazza si affollano), i dieci fantini che le Contrade hanno
ingaggiato, rivestiti con i colori che li distinguono (sulle spalle,
ben in vista, l'emblema), montano a cavallo a pelo, nel punto di
raccolta (Cortile del Podestà del Palazzo Comunale).
Preceduti dallo scoppio del mortaretto, si avviano a passo verso la
partenza: uno slargo davanti allo sbocco della Costarella dei Barbieri,
di fronte al Palco dei Giudici e dei Capitani. Due enormi canapi sono
tesi: il primo, lungo tutta la pista; il secondo, con un'apertura
attraverso la quale, cavalli e fantini, nell'ordine già conosciuto ma
dipendente dalla sorte, si pongono in allineamento secondo gli ordini
del "mossiere " da cui dipendono. L'ultima Contrada entra con il
cavallo già lanciato.
E a questo punto che il "mossiere", dal "verrocchio" (un palchetto con
un congegno), preme il pedale e fa abbassare il canape.
I dieci corridori, percorrendo tre giri della pista (quasi un
chilometro), provano a carriera, qualcuno a galoppo, altri - dopo le
prime falcate - addirittura a trotto, le proprie doti. Gli abili
fantini rilevano subito quali sono le lacune, quali le capacità, quale
il sistema migliore per affrontare le curve (due ad angolo retto:
quella di San Martino in discesa e quella del Casato in salita), se è
giusto il morso, se occorre apportare modifiche ai ferri, se ci sono
difetti da correggere. La baldanza e lo sconforto si alternano nei
senesi.
Ormai, il sottile velo che fa da sipario alla realtà temporale, si è
rotto. In quei quattro giorni, scrivono i reporters con disinvolta
meraviglia, il Palio sovrasta tutto. È vero. Se ne vanno via i pensieri,
gli affanni, scompaiono le piccole, banali questioni ripetitivamente
quotidiane, si rimandano le decisioni, gli appuntamenti, i contratti.Un
soffio di eternità, sui cui misteri non si indaga perché è contenuta
nel cuore quasi per naturale innesto, si impadronisce della mente e
del comportamento.
L'attesa è lunghissima. Quattro giorni che non passano mai, che si
misurano con un orologio diverso sul quale affiorano ricordi e affanni
lontani, e non sappiamo fin dove sono nostri e fin dove sono riverbero
di persone scomparse, ieri o cinque secoli fa.
Nomi di cavalli, di fantini, di Contrade, sono sulla bocca di tutti. Agli
angoli delle strade, sopratutto nei pressi delle Sedi o delle stalle
delle Contrade, nelle Società, i commenti, i punti di vista, i consensi,
i dissapori, le speranze, sono oggetto delle più disparate valutazioni.
La gente ha bisogno di ritrovarsi più di sempre; di stare vicina, di
sentirsi unita anche nel contatto. L'esasperazione cresce. Senesi che
abitano o, disgraziatamente, sono costretti a lavorare lontano dalla
propria città, dalla propria, piccola "patria", tornano appositamente
in questi giorni di passione (lasciando ad altri, magari, le ferie
natalizie o pasquali). E una costante immersione in un'atmosfera
realmente carica di eventi da cui ci si può distrarre solo con uno
sforzo di volontà, che costa fatica e tribolazione, tuttavia. Una
specie di autosuggestione per non accorarsi troppo. Un'autoanestesia
quasi codarda che si esprime, per certe persone, nel non andare in
Piazza del Campo (specialmente il giorno del Palio), rimanere chiusi
in casa o in attesa nella Chiesa o nella Società di Contrada: tensione,
paura dell'infarto, del malore.
Le "prove" si ripetono alla mattina e nel tardo pomeriggio, il giorno
dopo e il giorno dopo ancora: alla vigilia. Il drappellone viene
recato, in corteo, alla Collegiata di Provenzano il 1° luglio, dopo la
"prova generale" (o il 14 agosto, durante la "processione dei ceri ",
persistente ricordo del passato, al Duomo). Sarà rimosso il giorno del
Palio e posto direttamente nel carroccio del corteo.
La sera della vigilia, si tenta in qualche modo di soffocare nella
letizia l'incubo e l'apprensione. Una grande cena riunisce i
contradaioli (ormai nelle strade, perché i locali pur spaziosi delle
Società non riescono a contenere tutti): sono quattrocento, settecento,
mille. Dipende da Contrada a Contrada. Anche per i turisti, con una
prenotazione tempestiva, c'è posto e buona accoglienza. Essi possono
acquistare anche il foulard originale della Contrada, facendo attenzione
a quando e dove se ne ammantano, perché è un atto di appartenenza (sia
pure straordinaria), e comporta certe responsabilità e coraggio.
Alla cena parlano d'obbligo: il Capitano (il suo è sempre un discorso
di promessa, anche quando è cauto per le non favorevoli circostanze:
promessa di vincere, di ostacolare l'avversaria, di correre con onore);
il Priore (il discorso è di richiamo all'unità, alla serenità, alla
fortuna); il fantino (solitamente molto conciso quando non è addirittura
reticente).
La letizia puntualmente arriva con gli stornelli, con il marziale canto
dell'inno ufficiale, con qualche bottiglia di vino in più; ma è sempre
superficiale.
Si chiama "cena propiziatoria" e serve puntigliosamente una sua
ritualità. Si avverte, comunque, che non è una cena distensiva, una
baldoria, un appuntamento spensierato.
Il fantino si ritira di buon'ora. Il Capitano e i Tenenti spesso
scompaiono per gli ultimi abboccamenti con i rappresentanti di Contrade
amiche o aggregate. Tutto questo lavorìo di contatti, accordi, contro
- accordi (che non ha inizio né fine ma che praticamente, si riveste di
sostanziosità nei giorni dell'azione), si chiama, in termine senese,
"fare i partiti". E qui, la frase, può avere molti significati, tutti
concomitanti o convergenti: "dare e avere consiglio", "far la propria
parte", "far combriccola", "raggrupparsi in fazione". Si dice che un
tempo avessero la loro importanza con reali sviluppi nel corso del
Palio. In diversi casi alcuni cronisti descrivono, e certi comportamenti
rispecchiano, l'esistenza di patti precostituiti. Altrimenti non
verrebbero spiegate molte cose. Nel corso di questo secolo però, la
fortuna ha sempre inciso in maniera determinante sull'andamento del
Palio, in molti casi prescindendo dalla velocità del cavallo o
dall'abilità del fantino.
Ma, come in tutte le tensioni tirate allo spasimo, anche il Palio si
tinge di giallo: è una nota troppo invitante per novellieri o
romanzieri, perché sia abbandonata.
Il Palio è, scusandoci per la banalità della metafora, una battaglia
che tutti vogliono vincere ad ogni costo. Anche l'illecito (se non
espresso platealmente, altrimenti chi lo attua si trova isolato), può
divenire lecito. Intelligenza, furbizia, diplomazia alla Machiavelli,
finanza, sussistenze tecniche o scientifiche, sono mobilitate. La
Contrada deve riuscire: non si può mai attendere o rinviare o
rinunziare. Potrebbero passare gli anni (venti, trenta anni: un'intera
generazione si può dire) senza assaporare il magico momento del
trionfo. Le iniziative, la dedizione, i sacrifici spesso di molti anni,
sono appesi al drappellone, fetta di seta dipinta, che simboleggia la
dignità di superare tutti nel rappresentare il giorno di Siena.
Per questo, propriò perché tutti hanno una mèta comune, la favola
della corsa truccata non regge. Chi la sostiene, conosce il Palio
come si può conoscere un lontano pianeta dai romanzi di fantascienza. Può
accadere che ci siano scontri tra rivali in corsa; che l'insufficienza
delle doti del cavallo avuto in sorte, consigli un'azione diretta
sull'antagonista che ha ricevuto mezzi adatti per vincere. Ma anche qui
non si tratta dell'effetto del denaro, ma di una precisa volontà e (se è
seguito nello spirito della tradizione) di un quasi - dovere.
Impedire all'avversario di vincere è il punto numero due del
programma. Anche concedendo ad altre concorrenti capaci di opporsi
con validi mezzi, il proprio denaro o il proprio fantino. Anche
tramando, perché la piazza non offra fantini di eccelsa reputazione
allo schieramento ostile, o tentare di rompere regole antiche per
cercarne altre inesplorate. Ma è casuale e difficile l'abbandono del
punto numero uno che è e resta quello di vincere.
|
|
TUTTI I CAPITOLI DEL LIBRO
|
|